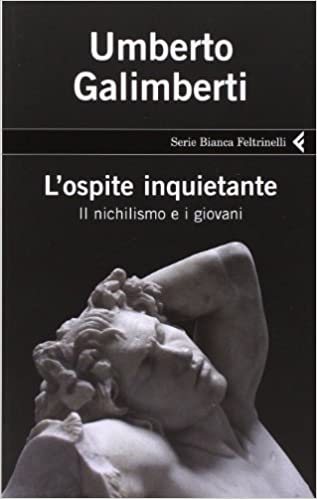
APPUNTI E RIFLESSIONI
Perché un libro sui giovani: perché i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui.
Interrogati non sanno descrivere il loro malessere perché hanno ormai raggiunto quell’analfabetismo emotivo che non consente di riconoscere i propri sentimenti e soprattutto di chiamarli per nome. Perciò le parole che alla speranza alludono, le parole di tutti più o meno sincere, le parole che insistono, le parole che promettono, le parole che vogliono lenire la loro segreta sofferenza languono intorno a loro come rumore insensato.
Il disagio non è più psicologico, ma culturale. E allora è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime.
Non è in questo prescindere dai giovani il vero segno del tramonto della nostra cultura?
Dalle nostre effettive capacità, quanto l’arte del vivere (téchne toũ bíou) come dicevano i Greci, che consiste nel riconoscere le proprie capacità (gnõthi seautón, conosci te stesso) e nell’esplicitarle e vederle fiorire secondo misura (katà métron).
Il paradigma tecnico-scientifico, infatti, non si propone alcun fine da realizzare, ma solo dei risultati da raggiungere come esiti delle sue procedure.
La tecnica, infatti, non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità: la tecnica funziona.
Due studiosi hanno posto sotto osservazione i servizi di consulenza psicologica e psichiatrica diffusi in Francia e si sono accorti che a frequentarli, per la gran parte, sono persone le cui sofferenze non hanno una vera e propria origine psicologica, ma riflettono la tristezza diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento permanente di insicurezza e di precarietà; la crisi non è tanto del singolo quanto il riflesso nel singolo della crisi della società
In che cosa consiste questa crisi? In un cambiamento di segno del futuro: dal futuro-promessa al futuro-minaccia. E’ la fine dell’ottimismo teologico che visualizzava il passato come male, il presente come redenzione, il futuro come salvezza.
Questa visione ottimistica della storia, dove la triade colpa, redenzione, salvezza trovava la sua riformulazione in quell’omologa prospettiva dove il passato appare come male, la scienza o la rivoluzione come redenzione, il progresso (scientifico o sociologico) come salvezza.
Inquinamenti di ogni tipo, disuguaglianze sociali, disastri economici, comparsa di nuove malattie, esplosioni di violenza, forme di intolleranza, radicamento di egoismi, pratica abituale della guerra hanno fatto precipitare il futuro dall’estrema positività della tradizione giudaico-cristiana all’estrema negatività di un tempo affidato a una
casualità senza direzione e orientamento. E questo perché, se è vero che la tecno-scienza progredisce nella conoscenza del reale, contemporaneamente ci getta in una forma di ignoranza molto diversa, ma forse più temibile, che è poi quella che ci rende incapaci di far fronte alla nostra infelicità e ai problemi che ci inquietano e che paurosamente ruotano intorno all’assenza di senso. Per dirla con Spinoza, viviamo in un’epoca dominata da quelle che il filosofo chiama le
le “passioni tristi”, dove il riferimento non è al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla disgregazione e alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre a cui l’Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà.
La mancanza di un futuro come promessa arresta il desiderio nell’assoluto presente. Meglio star bene e gratificarsi oggi se il domani è senza prospettiva.
La mancanza di un futuro come promessa priva genitori e insegnanti dell’autorità di indicare la strada.
Ma è anche vero che le passioni tristi sono una costruzione, un modo di interpretare la realtà, non la realtà stessa, che ha ancora in serbo delle risorse se solo non ci facciamo irretire da quel significante oggi dominante che è l’insicurezza.
La scuola ha a che fare con quella fase precaria dell’esistenza che è l’adolescenza, dove l’identità appena abbozzata non si gioca come nell’adulto tra ciò che si è e la paura di perdere ciò che si è, ma nel divario ben più drammatico tra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire a essere ciò che si sogna.
Adolescenze non desideranti annunciano esistenze mancate, ma il desiderio è spesso in conflitto con la realtà che non è costruita apposta per soddisfare desideri. Qui sono possibili due atteggiamenti. O la rimozione della realtà con conseguente rifugio in un mondo sognato ad essa alternativo, o la frustrazione che, reiterata, annulla
l’identità.
In questo scontro fra realtà e desiderio in cui si dibatte l’adolescenza può scattare la frustrazione, che è utilissima per crescere, ma che, come tutte le medicine efficaci, va dosata. Un eccesso di frustrazione – come nel caso di voti troppo bassi distribuiti in nome dell’oggettività delle prove, senza il minimo sospetto che dietro le prove c’è
qualcuno che ci prova e che si mette alla prova – sposta altrove la ricerca di riconoscimento senza il quale non si costruisce alcuna identità e quindi non si può vivere.
I giovani cercano i divertimenti perché non sanno gioire. Ma la gioia è innanzitutto gioia di sé, quindi identità riconosciuta, realtà accettata, frustrazione superata, rimozione ridotta al minimo.
E come non si può fare i corazzieri se si è alti un metro e cinquanta, cominciamo a chiederci perché si può insegnare per il solo fatto di possedere una laurea, senza alcuna richiesta in ordine alla competenza psicologica, alla capacità di comunicazione, al carisma. Sì, proprio il carisma.
E così per tutta l’adolescenza e la prima giovinezza, quando massima è la forza biologica, emotiva e intellettuale, i nostri ragazzi vivono parcheggiati in quella terra di nessuno dove la famiglia non svolge più alcuna funzione, la scuola non desta alcun interesse, la società alcun richiamo, dove il tempo è vuoto, l’identità
non trova alcun riscontro, il senso di sé si smarrisce, l’autostima deperisce.
L’eccesso emozionale e la mancanza del raffreddamento riflessivo portano sostanzialmente a quattro possibili esiti: 1) lo stordimento dell’apparato emotivo attraverso quelle pratiche rituali che sono le notti in discoteca o i
percorsi della droga; 2) il disinteresse per tutto, messo in atto per assopire le emozioni attraverso i percorsi dell’ignavia e della non partecipazione che portano all’atteggiamento opaco dell’indifferenza; 3) il gesto violento, quando non omicida, per scaricare le emozioni e per ottenere un’overdose che superi il livello di
assuefazione come nella droga; 4) la genialità creativa, se il carico emotivo è corredato da buone autodiscipline.
Il tutto condito da un acritico consumismo, reso possibile da una società opulenta, dove le cose sono a disposizione prima ancora che sorga quell’emozione desiderante, che quindi non è sollecitata a conquistarle, e perciò le consuma con disinteresse e snobismo in modo individualistico, dove il pieno delle cose sta al posto del
vuoto delle relazioni mancate.
Oggi l’educazione emotiva è lasciata al caso e tutti gli studi e le statistiche concordano nel segnalare la tendenza, nell’attuale generazione, ad avere un maggior numero di problemi emotivi rispetto a quelle precedenti. E questo
perché oggi i giovanissimi sono più soli e più depressi, più rabbiosi e ribelli, più nervosi e impulsivi, più aggressivi e quindi impreparati alla vita, perché privi di quegli strumenti emotivi indispensabili per dare avvio a
quei comportamenti quali l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, senza i quali saranno sì capaci di parlare, ma non di ascoltare, di risolvere i conflitti, di cooperare.
Nel deserto della comunicazione emotiva che da piccoli non ci è arrivata, da adolescenti non abbiamo incontrato
e da adulti ci hanno insegnato a controllare, fa la sua comparsa il gesto, soprattutto quello violento, che prende il posto di tutte le parole che non abbiamo scambiato né con gli altri per istintiva diffidenza, né con noi stessi per afasia emotiva. E allora prima del lettino dello psicoterapeuta dove le parole si scambiano, come è noto, a
pagamento, prima dei farmaci che soffocano tutte le parole con cui potremmo imparare a nominare e a conoscere i nostri moti d’anima, dobbiamo convincerci della necessità e dell’urgenza di un’educazione emotiva preventiva, di cui scarsissime sono le occasioni in famiglia, a scuola e nella società.
E i figli, come gli animali, sentono quando c’è la paura dei genitori, e, quando non c’è, sentono il loro sostanziale disinteresse emotivo. Soli da piccoli, affidati alla televisione o alle prestazioni mercenarie dell’esercito delle baby-sitter, questi figli, figli del benessere e della razionalità, crescono con un cuore dapprima
tumultuoso che invoca attenzione emotiva, poi, quando questa attenzione non arriva, giocano d’anticipo la delusione e il cinismo per difendersi da una risposta d’amore che sospettano non arriverà mai.
In questo modo molti giovani scambiano la loro identità con la pubblicità dell’immagine e, così facendo, si producono in quella metamorfosi dell’individuo che non cerca più se stesso, ma la pubblicità che lo costruisce.
Per effetto di questa esposizione, che abolisce la parola segreta, quella intima, quella nascosta, il pudore, per loro, non è più un sentimento umano, il tracciato di un limite. La parola che li espone pubblicamente ha rotto i confini, e l’anima, che un giorno abitava il segreto della loro interiorità, si è esteriorizzata
Nessuno, infatti, come Platone, ha mai indagato la natura del desiderio, cogliendone l’essenza nell’insaziabilità, perché il desiderio è mancanza, è vuoto, da pensare non come uno stato stabile contrario al pieno, ma come uno stato insaturabile che si svuota man mano che cerchiamo di riempirlo, come la “giara bucata”, per stare alle
immagini di Platone, o come il “piviere” che è quell’uccello che mangia e nel contempo evacua3(Sissa, p. 10).
Il piacere dell’anestesia è il più sottile dei piaceri, forse il più insidioso, senz’altro il più diffuso. Lo incontriamo ogni volta che accendiamo una sigaretta per attutire noia o stress, piccoli indizi della fatica di vivere, ogni volta che ci affidiamo all’alcol per liberare quanto siamo costretti abitualmente a reprimere. Tutto ciò avviene quando
si è detto sì alla vita e ci si vuol solo sostenere per mantenere la promessa. Quando invece alla vita si è detto no, senza neppure bisogno di dirlo perché è la vita stessa a non essere mai sorta come una passione, allora si cerca un piacere anestetico più forte, che vuol dire cercare un modo qualsiasi per non esserci.
Il piacere della droga non è la scelta di una maggiore intensità della vita al prezzo della sua brevità, è la scelta dell’astinenza dalla vita, perché questa, una volta apparsa in tutta la sua insignificanza, prosegua pure il tracciato della sua insensatezza, ma risparmiando almeno il dolore. A questo tende il piacere della droga, ossia il piacere dell’anestesia, a null’altro.
I giovani sono attivi quando con la speranza vanno verso il tempo e non quando con l’attesa aspettano che il tempo venga verso di loro.
Se un giorno è come tutti, tutti i giorni sono come uno solo, nell’uniformità perfetta di una vita che assapora quel vuoto d’esperienza che accade quando si sono vanificate tutte le attese, tutte le speranze, tutte le illusioni. È allora che l’impossibile, come un muro, sbarra tutte le vie del possibile che alimentano il futuro. E lo spazio
lasciato vuoto dal futuro, disertato sia dall’attesa sia dalla speranza, viene occupato dal dilagare del passato che divora tutte le attese e tutte le speranze sottraendo al tempo la sua dimensione a venire. È a questo punto che dalla noia si passa alla depressione, sempre più diffusa tra i giovani.